
Avviare una startup in Italia significa affrontare sfide complesse ma anche poter contare su diverse opportunità di sostegno economico.
Le nuove imprese, soprattutto nei primi mesi di vita, hanno bisogno di risorse per consolidare il progetto, sviluppare il prodotto e sostenere i costi di gestione.
Tuttavia, le fonti di finanziamento non sono tutte uguali: ciascuna presenta vantaggi, vincoli e obiettivi differenti.
Comprendere le caratteristiche di ciascuna è il primo passo per individuare la strategia più adatta alla propria idea imprenditoriale.
I costi coperti dai primi finanziamenti
Nella fase iniziale di un progetto, i fondi ottenuti attraverso bandi, investitori o prestiti vengono generalmente utilizzati per coprire le spese più immediate e strategiche. Tra queste troviamo i costi di sviluppo del prodotto o del servizio, come la creazione di prototipi, l’acquisto di materiali o la realizzazione di software.
Un’altra voce importante è il marketing: costruire il brand, lanciare il sito web, comunicare con i potenziali clienti e partecipare a fiere o eventi richiede un investimento significativo. Anche le risorse umane pesano sul bilancio iniziale: una startup deve spesso remunerare sviluppatori, consulenti, figure commerciali o marketing specialist per poter crescere.
A questi si aggiungono le spese legali e amministrative (costituzione della società, tutela del marchio, consulenze contabili), oltre a quelle infrastrutturali, come l’acquisto di macchinari, server o licenze software.
Infine, una parte del capitale iniziale viene destinata alla ricerca e sviluppo, ai test e, in alcuni casi, alla brevettazione delle innovazioni.
Le principali fonti di finanziamento
Nel nostro paese, le startup possono contare su tre principali canali di finanziamento:
i contributi a fondo perduto, gli investimenti da parte di Venture Capital e Business Angel, e il debito bancario. Ognuno di questi strumenti risponde a esigenze diverse e si adatta a differenti fasi di crescita dell’impresa.
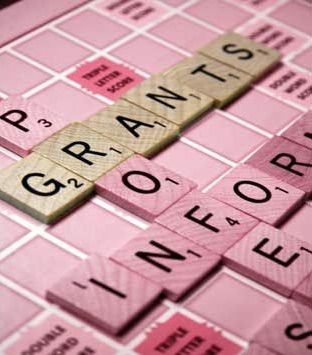
I contributi a fondo perduto rappresentano una delle forme di finanziamento più attrattive per le startup, perché non prevedono la restituzione delle somme ottenute. Si tratta di fondi pubblici, gestiti principalmente dalle Regioni o da Enti nazionali, destinati a sostenere specifici settori come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale o la digitalizzazione.
Il grande vantaggio di questa forma di sostegno è evidente: il capitale ottenuto non deve essere rimborsato e può coprire una parte consistente dei costi di avvio o sviluppo. Inoltre, in alcuni casi, i grant sono cumulabili con altri strumenti come crediti d’imposta o fondi di garanzia.
Tuttavia, l’accesso a questi contributi non è automatico. È necessario partecipare a bandi pubblici, spesso con requisiti stringenti, e presentare un progetto dettagliato che superi una valutazione tecnica ed economica. I bandi hanno finestre temporali di apertura limitate, e non è scontato entrare in graduatoria. Per questo motivo, la pianificazione e la precisione nella presentazione della domanda sono elementi cruciali, così come può essere utile affidarsi a consulenti esperti per la stesura del progetto.

Un’altra possibilità per finanziare la crescita di una startup è aprirsi all’ingresso di investitori privati. I Business Angel sono persone fisiche, spesso imprenditori o manager con esperienza, che investono capitali propri in progetti promettenti. Oltre alle risorse economiche, mettono a disposizione il loro network e il loro know-how, diventando veri e propri mentori per i fondatori.
I Venture Capital, invece, sono fondi di investimento specializzati che operano in modo strutturato. Intervengono in startup ad alto potenziale di crescita, generalmente in cambio di quote societarie, con l’obiettivo di ottenere un ritorno economico nel medio periodo.
Questo tipo di finanziamento ha diversi punti di forza. Gli investitori non solo sostengono economicamente la startup, ma la accompagnano nel percorso di crescita, contribuendo con competenze e relazioni strategiche. Hanno inoltre un interesse diretto al successo del progetto e, se persone fisiche, beneficiano di un’importante agevolazione fiscale per il 2025: una detrazione del 65% sull’investimento in startup innovative.
Di contro, convincere investitori di questo tipo non è semplice. Richiedono documentazione dettagliata, piani finanziari solidi e la dimostrazione di un reale potenziale di mercato. Inoltre, in Italia il numero di Venture Capital e Business Angel è ancora limitato rispetto ad altri paesi europei. Entrando in società, questi soggetti ottengono anche poteri decisionali, e sono noti per la loro attenzione alla performance e alla governance. Collaborare con loro, quindi, significa accettare una relazione intensa e strutturata, ma spesso determinante per la crescita dell’impresa.

Il debito bancario rimane una forma di finanziamento più tradizionale ma ancora oggi rilevante per molte startup. Si tratta di capitali concessi dalle banche sotto forma di prestiti o mutui, che devono essere restituiti nel tempo insieme agli interessi.
Pur non essendo lo strumento più flessibile, il credito bancario rappresenta una valida opzione in assenza di alternative immediate. Il vantaggio principale è che non comporta la cessione di quote o poteri societari, permettendo ai fondatori di mantenere il controllo dell’impresa.
Tuttavia, ottenere un finanziamento bancario non è semplice per una startup. Le banche richiedono garanzie reali o personali e tendono a preferire aziende con uno storico finanziario consolidato. A differenza dei grant o degli investimenti di capitale, il debito deve essere restituito, e il peso degli interessi può incidere sul flusso di cassa nei primi anni di attività.
Negli ultimi anni, però, sono stati introdotti programmi statali e regionali che fungono da garanti, riducendo il rischio per le banche e abbassando i tassi d’interesse per le startup. Tra questi, il Fondo di Garanzia per le PMI e startup è uno degli strumenti più utilizzati e rappresenta un sostegno concreto per l’accesso al credito.
Consiglio finale: la via migliore resta il finanziamento interno
Quando possibile, la forma di finanziamento più sana è quella che proviene dalle prime vendite. Il flusso di cassa generato dal fatturato, anche se limitato, rappresenta un segnale di solidità e sostenibilità del modello di business.
Sebbene difficilmente possa coprire tutte le esigenze di sviluppo, il finanziamento interno aiuta a mantenere il controllo della società e a ridurre la dipendenza da fonti esterne. Inoltre,
la presenza di fatturato rende più semplice accedere a bandi, investitori e prestiti bancari, poiché dimostra che la startup ha già un mercato e una capacità di generare valore.
In definitiva, il percorso ideale è quello che combina l’autofinanziamento con le altre forme di sostegno disponibili, costruendo passo dopo passo una base economica solida e una crescita sostenibile nel tempo.
Niccolò Lastrucci
Junior Business Development Consultant
